La maggior parte dei ricercatori italiani all’estero non ha alcuna intenzione di tornare in Italia: secondo un recente studio coordinato da Benedetto Torrisi, ricercatore in statistica economica all'università di Catania, su un campione di quasi mille ricercatori espatriati con un’età compresa tra i 25 ed i 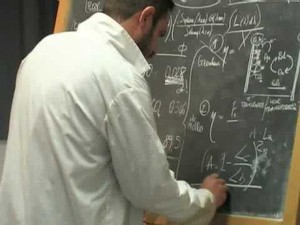 40 anni, il 73% risiede fuori dai confini nazionali felicemente. La restante percentuale invece tornerebbe solo a determinate condizioni: ricongiunzione della carriera acquisita, maggiori redditi, migliore gestione delle risorse destinate alla ricerca e maggiori rapporti tra università e impresa. Lo stato di benessere sociale e lavorativo raggiunto negli altri paesi è infatti giudicato molto soddisfacente, e la quasi totalità ritiene non meritocratico l’accesso ai finanziamenti per la ricerca in Italia.
40 anni, il 73% risiede fuori dai confini nazionali felicemente. La restante percentuale invece tornerebbe solo a determinate condizioni: ricongiunzione della carriera acquisita, maggiori redditi, migliore gestione delle risorse destinate alla ricerca e maggiori rapporti tra università e impresa. Lo stato di benessere sociale e lavorativo raggiunto negli altri paesi è infatti giudicato molto soddisfacente, e la quasi totalità ritiene non meritocratico l’accesso ai finanziamenti per la ricerca in Italia.
Lo studio ha anche indagato tra le motivazioni che spingono a lasciare il Belpaese. Ne è emerso che nel 95,7% dei casi i nostri migliori cervelli emigrano per inseguire migliori opportunità occupazionali, attratti dal prestigio dell’istituzione ospitante e dall’innovazione delle tematiche di ricerca, e, ancora, incentivati da motivi economici. Più nello specifico, i principali fattori di richiamo risiedono – in base allo studio - nell’efficace organizzazione del lavoro, nelle sue strutture, nelle politiche applicate e nelle prospettive di carriera. Un insieme di valutazioni che, in definitiva, finisce per far sfumare del tutto la voglia di rientrare.
L’indagine però non si ferma ai cervelli in fuga. Al primo progetto iniziato nel 2009 (Italian researchers abroad), si aggiunge nel 2010 la visione dell'altra faccia della medaglia con Italian researchers in Italy, ovvero di chi rimane in Italia. Dall'analisi di un campione di 3575 individui tra precari e non, è risultato che la maggiore tendenza a emigrare è legata ai più giovani (due su cinque tra i 25-30enni), e al contempo questa percentuale si riduce con il crescere dell'età. I motivi? Da buoni italiani è l’attaccamento alla famiglia a primeggiare (per quattro intervistati su cinque), seguita dai rapporti sociali e dall’adattamento al sistema universitario nazionale. Quello che invece spinge ad andare via è per l’83% la maggiore valorizzazione delle proprie competenze, seguita dai maggiori redditi, dalle opportunità occupazionali, e perfino dall’eccessiva e farraginosa burocrazia italiana (per il 42%). E naturalmente i dati fanno registrare di riflesso anche la pessima opinione sullo stato delle cose in Italia in fatto di ricerca. Non è un caso se solo uno su sette ritiene di vivere in un ambiente lavorativo «con un'alta percezione del benessere organizzativo», mentre tra quelli che vivono all’estero la percentuale sale a nove su dieci.
è per l’83% la maggiore valorizzazione delle proprie competenze, seguita dai maggiori redditi, dalle opportunità occupazionali, e perfino dall’eccessiva e farraginosa burocrazia italiana (per il 42%). E naturalmente i dati fanno registrare di riflesso anche la pessima opinione sullo stato delle cose in Italia in fatto di ricerca. Non è un caso se solo uno su sette ritiene di vivere in un ambiente lavorativo «con un'alta percezione del benessere organizzativo», mentre tra quelli che vivono all’estero la percentuale sale a nove su dieci.
Infine c’è un aspetto che incuriosisce. Nonostante la considerazione quasi del tutto negativa delle proprie condizioni di lavoro, se si chiede oggi a un ricercatore la sua disponibilità a trasferirsi altrove traspare solo una «prudente propensione a emigrare». «Forse si è in attesa dei risvolti della riforma dell’università? Forse la congiuntura economica internazionale sfavorevole?», si domanda Torrisi. Fatto sta che chi si trova all’estero per il momento non pensa di rimpatriare, mentre i ricercatori che decidono di restare, nonostante le forti critiche al paese, lo fanno ancorandosi a un incrollabile ottimismo.
Ilaria Mariotti
Per saperne di più su questo argomento, leggi anche:
- Dieci buoni motivi lasciare l’Italia (e poi tornare): l'editoriale di Alessandro Rosina
Community